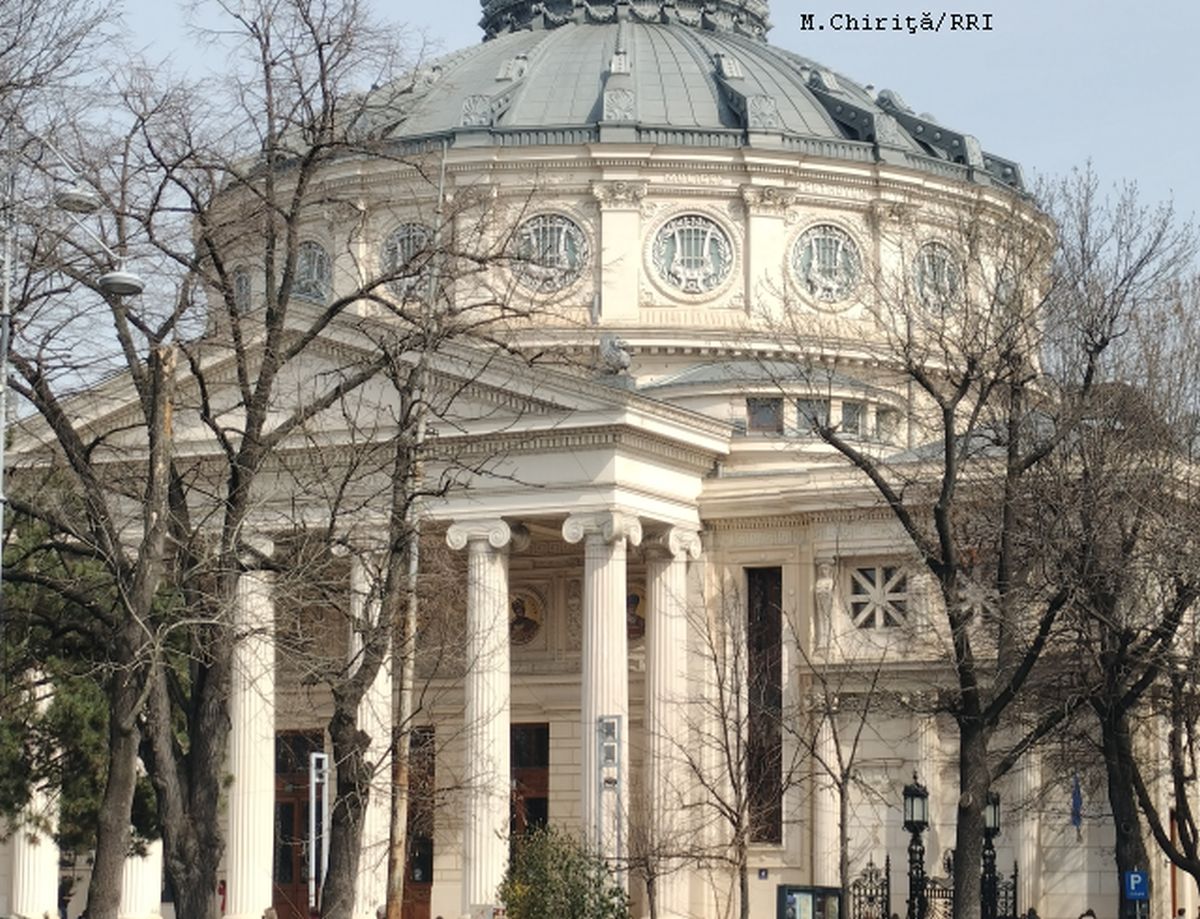Nato nell’agosto del 1903, il principe Nicolae è stato l’unico fratello di re Carlo II a diventare maturo, perché l’altro, Mircea, è morto quanto era ancora bambino. Allevato dalla regina Maria in una maniera affatto restrittiva, Nicolae è stato energico da piccolo, appassionato sin dalla giovinezza di sport e automobilismo e influenzato dallo spirito britannico durante gli studi all’Eton College. Per sfortuna, per il pubblico largo, Nicky, com’era chiamato dalla famiglia, rimane ancora uno sconosciuto anche perché ha passato gran parte della sua vita in esilio. Forse la parte più conosciuta della sua attività pubblica è stata la partecipazione alla reggenza insediata tra il 1927 e il 1930, nel periodo in cui il trono è spettato a re Michele che era minorenne, fino al ritorno di Carlo II. Il motivo dell’esilio del principe Nicolae fu il matrimonio morganatico – non accettato dalla casa reale – con Ioana Doletti. Sebbene suo fratello, Carlo, abbia avuto, a suo turno, un matrimonio simile, questo fatto non l’ha impedito di esiliarlo subito dopo aver recuperato il trono nel 1930. Quindi, la separazione dalla Romania iniziata nel periodo tra le due guerre si è prolungata anche nel dopoguerra, con l’insediamento del comunismo.
Proprio questo periodo è stato studiato da Diana Mandache nel suo recente libro intitolato „Il principe Nicolae. Esilio e rivalità”, volume per il quale l’autrice si è documentata sia negli archivi nazionali, che in quelli all’estero. L’autrice del libro, Diana Mandache, ci ha parlato della personalità del principe Nicolae e della sua influenza sulla diaspora romena: Nicolae aveva un carattere fermo. Era temperamentale, ma allo stesso tempo aveva un’educazione britannica, grazie ai suoi studi e al fatto che aveva vissuto in Gran Bretagna per un lungo periodo, negli anni di formazione, subito dopo la fine della prima guerra mondiale. Inoltre, aveva avuto come tutor colui che era stato il tutor anche dei figli di re Giorgio V, il cugino della regina Maria. E’ una cosa fondamentale aver avuto dei mentor che gli modellassero la personalità e che lo consigliassero in determinati momenti della sua vita. Lo storico Nicolae Iorga, che ha apprezzato moltissimo il principe Nicolae, affermava che per il gesto significativo di aver accettato di far parte della reggenza, lui si sarebbe tolto il cappello e si sarebbe piegato fino alla terra davanti a lui perché in quel momento Nicolae aveva garantito la stabilità della dinastia e una certa sicurezza della vita politica tramite la sua partecipazione alla reggenza. Re Michele era allora minorenne e la reggenza era formata da tre persone: il patriarca Miron Cristea, Gheorghe Buzdugan, che nel 1927 era presidente dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, e Nicolae, che era stato pregato di farlo qualche tempo prima dalla regina Maria. Quindi, dal punto di vista morale, era preparato, ma era difficile rinunciare a quell’età, tuttavia molto giovane, alla vita personale.
Con l’esilio definitivo nel 1937, Nicolae cominciò un’attività diplomatica in esilio prima a Venezia, dove ha abitato inizialmente, poi in Svizzera, a Losanna. Diana Mandache continua: Negli anni 1940 ebbero luogo incontri con diplomatici romeni e furono esaminati argomenti importanti, oltre ai problemi politico-militari della seconda guerra mondiale e la necessità di entrare in guerra dalla parte degli alleati, ovvero il cambiamento della politica estera. Egli pensava alla creazione di un comitato dei romeni liberi, cosa che non sarebbe stata possibile, in quanto la Svizzera, da stato neutro, non permetteva attività politiche. Però ebbe incontri con diplomatici stranieri degli stati alleati. Un personaggio importante fu l’ambasciatore degli Stati Uniti, Leland Harrison, che conosceva il caso di Nicolae già dal 1937, quando era accreditato a Bucarest. Forse anche per questo la densità degli incontri con lui e con il ministro della Gran Bretagna a Berna occupò un posto importante nella vita del principe Nicolae in quel periodo. Lui aveva in mente di rivedere o di formulare un’altra costituzione e per tale motivo aveva assunto un esperto di giurisprudenza svizzero, fatto menzionato da questo alle autorità di Berna perché era necessario riferire che aveva certi interessi o atteggiamenti politici. Il principe Nicolae venne ammonito dalle autorità di Berna, verbalmente, tramite un intermediario, in maniera molto diplomatica, di cessare questi incontri politici, che a volte si svolgevano sotto la forma di ricevimenti o incontri privati. Evidentemente, aveva il permesso di esprimere le proprie opinioni, ma non di più, la Svizzera essendo uno stato neutro e imparziale.
Dopo la comunistizzazione della Romania, l’attività in esilio del principe Nicolae si intensificò e trovò un settore prediletto nella cultura, nel tentativo di unificare la diaspora romena estremamente divisa, racconta sempre la storica Diana Mandache: Dopo il 1947, l’attenzione del principe Nicolae si spostò verso altri stati, come la Francia, Paese verso il quale si era verificata una forte emigrazione politica dopo l’insediamento del regime comunista e la partenza del re dalla Romania. Anche verso la Spagna, dove gli esiliati erano, nella maggior parte, legionari. Il principe Nicolae ebbe un ruolo importante in questo periodo. Mandò in onda messaggi da Radio Madrid o Radio Roma in occasione della giornatà della monarchia romena, il 10 maggio, oppure in occasione del 24 gennaio, organizzò delle settimane romene. Cercò di unificare l’emigrazione nei Paesi menzionati, facendo visite alle associazioni o alle organizzazioni oppure nell’ambito delle comunità romene in Italia, Spagna, Francia. Questi furono i principali Paesi in cui svolse la sua attività. Rilasciò interviste alla stampa italiana, alla stampa spagnola, pubblicò dichiarazioni in merito alla situazione dei romeni nella Romania prigioniera, poi intervenne, ad esempio avendo consultazioni in merito all’attacco della Legazione della Repubblica Popolare Romena di Berna da parte del gruppo Oliviu Beldeanu. (…) Le questioni culturali hanno sempre interessato il principe Nicolae, che considerava la cultura un mezzo di propaganda. Durante la guerra fredda, le settimane romene che organizzò nella RFG, il sostegno alla Biblioteca Romena di Friburgo, la creazione, dopo la morte di sua moglie, della Fondazione Culturale Principessa Ioana oppure l’organizzazione di settimane romene a Madrid hanno riunito non solo i suoi sostenitori, ma anche i romeni in esilio che non sostenevano un determinato gruppo e non avevano orientamenti politici specifici. Le sue azioni ebbero successo, tant’è che vi parteciparono anche personalità della cultura romena, che volevano anche tenere conferenze sulla Romania. Dunque, per Nicolae, la Romania è stata prima di tutto un ideale.
Il principe Nicolae si spense nel 1978 a Madrid, essendo inzialmente sepolto a Losanna. Però, quest’anno, sia lui che sua moglie, Ioana Doletti, sono stati portati a Curtea de Argeș e sepolti di nuovo nella necropoli reale.